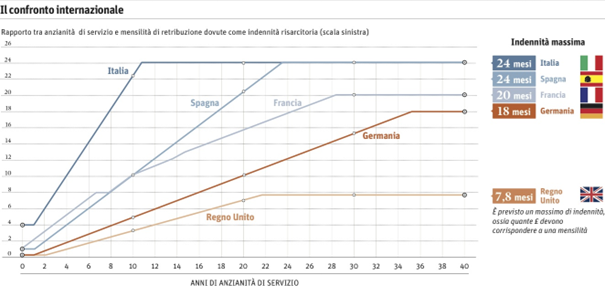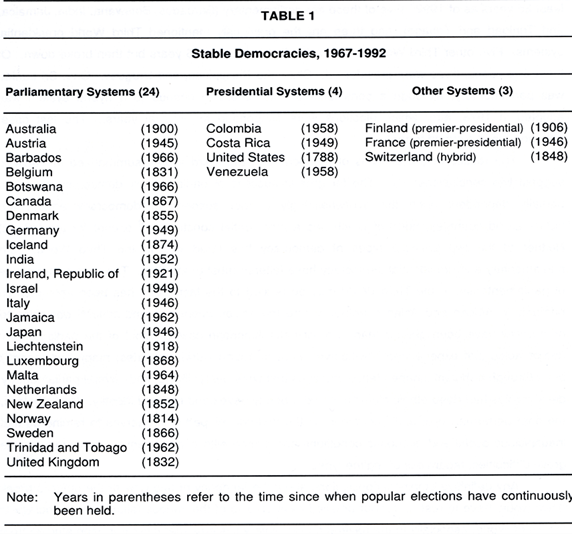Stellantis, i posti di lavoro e l’illusione dell’italianità. Che fare?
Immagine. 1960, quando l’auto italiana era innovazione: trazione anteriore, motore boxer a cilindri contrapposti montato di sbalzo, freni a disco sulle quattro ruote a doppio circuito, servosterzo, iniezione diretta (modello successivo).
Di Pierantonio Rumignani, PD Berlino e Brandeburgo
Sull’importante e un tempo economicamente più importante fronte dell’automobile le notizie non sono buone in Italia. Ciò spinge molti suoi politici a intervenire con forza e a colorare non di rado la realtà – anche usando fraseologie prese da un passato che si sperava dimenticato. Questo approccio confonde le cose e impedisce una riflessione matura e oggettiva. Così Meloni, facendo la voce grossa come sua abitudine anche quando ha solo scartine in mano, pesca nel passato remoto ed esige un’italianità nella produzione di auto che non esiste più in un mondo in cui la globalizzazione significa di necessità una ripartizione delle funzioni produttive a scavalcare i confini nazionali: “Se si vuole vendere auto sul mercato internazionale pubblicizzandola come gioiello italiano allora quell’auto deve essere prodotta in Italia questa la questione che dobbiamo porre”, rivolgendosi a Stellantis il 24 gennaio. In realtà vetture con il marchio Fiat vengono prodotte in modo crescente fuori dal nostro paese così come si costruiscono in Italia auto di altri marchi del gruppo Stellantis cui Fiat appartiene. Non solo: così come i modelli concorrono fra di loro sul mercato così anche gli impianti di uno stesso gruppo, disseminati in vari paesi, rivaleggiano al suo interno per la produzione dei veicoli sulla base della rispettiva efficienza produttiva. Ragionamenti analoghi valgono presso i fornitori dell’indotto. A mescolare ancora di più le carte, i marchi stessi sono divenuti, col crescere dell’agglomerazione in grandi gruppi, moduli indipendenti tra i fattori che fanno un prodotto e diventano intercambiabili a seconda del mercato. La nuova Fiat 600 elettrica, ad esempio, utilizzerà una piattaforma Peugeot e verrà prodotta in Polonia.
Coerentemente con il desiderio di “italianità” – anche il nome di un ministero è stato modificato in questo senso – potremmo attenderci in un futuro prossimo che si richieda, analogamente a quanto avvenuto in America con il trattato USCMA (ex-NAFTA), l’introduzione di quote minime di contenuto nazionale per i veicoli malgrado la complessità della realizzazione e gestione di una misura in tal senso in un contesto europeo caratterizzato da un grande numero di paesi relativamente piccoli che hanno fra l’altro un potenziale ridotto di verticalizzazione produttiva.
Senza dimenticare che tali tentativi sarebbero in Europa assai problematici già solo in considerazione del principio di libera di circolazione di persone fisiche, merci, servizi e capitale che è sancito per legge comunitaria (art. 63, Trattato sul funzionamento UE), occorre considerare che condizionamenti nazionali, o meglio nazionalistici, andrebbero inevitabilmente a detrimento della logica industriale e quindi della redditività delle case automobilistiche europee complicando fortemente la loro situazione in un mercato mondiale dove la difficile conversione verso nuove tecnologie unitamente alla preannunciata entrata massiccia dei produttori cinesi metteranno in prospettiva a dura prova la loro resilienza. La globalizzazione nel mondo dell’automobile è destinata a restare e per ragioni di necessità economica non si farà senz’altro più debole.
Altrettanto difficile è il tema dell’assetto azionario del gruppo Stellantis, anch’esso preso di mira dai critici, ove non pochi si dicono pubblicamente favorevoli al perseguimento da parte dello stato italiano dell’obiettivo di esercitare un’influenza politica sulle sue decisioni strategico-operative. In tale ottica si prospetta con enfasi un’entrata dello stato italiano nell’azionariato di Stellantis a bilanciare quella dello stato francese detenuta attraverso Bpi – un investimento che, secondo alcune veloci stime, potrebbe costare al nostro erario più di sei miliardi di euro se le due partecipazioni statali dovessero essere paritarie. Per tale ipotesi si pronuncia un ampio coro di voci che va da rappresentanti di governo (Meloni: “Si prenda sul serio l’ipotesi di una partecipazione italiana a Stellantis che bilanci quella francese”; Urso: “Noi vogliamo difendere l’interesse nazionale, instaurare un rapporto equilibrato con Stellantis.”) e dell’opposizione (Schlein: “Si studi concretamente la strada della partecipazione pubblica per incidere sulla strategia aziendale”) ad esponenti sindacali (Landini/CGIL: “Gli incentivi di per sé non risolvono e c’è bisogno di una logica di intervento più forte. In Francia è presente lo Stato. Torniamo a chiedere che anche lo Stato italiano entri. Lo chiediamo da tempo.” mentre altri sono invece restii come Bombardieri/UIL: “Come si fa a sostenere di vendere un pezzo di Poste e poi comprare un pezzo di Stellantis?”)
Apparentemente vi è difficoltà a riconoscere che Stellantis è una società quotata con un azionariato internazionale e che va attentamente vagliata la fattibilità dell’entrata nella proprietà di uno stato in una situazione non di crisi – come fu invece nel caso dello stato francese in PSA – e per di più con il fine scoperto di esercitare influenza a favore di soli “interessi nazionali”, per quanto con la motivazione che si spererebbe non di facciata a protezione dell’occupazione, con tutte le immaginabili complicazioni nei confronti di numerosi terzi, inclusi i governi di altri paesi europei che ospitano anch’essi unità operative del gruppo Stellantis e che potrebbero avere interessi antagonistici a quelli dello stato italiano. In tal senso una sua partecipazione nel capitale di Stellantis potrebbe avere ripercussioni negative per gli stessi intenti originari che derivano da un palese conflitto di interessi – già esistente con la partecipazione dello stato francese.
Ci si dovrebbe attendere invece che ci si occupi in cima a tutte le priorità del tema relativo all’attrattiva degli investimenti in Italia e, in questo caso particolare, nel settore dell’auto e si risponda al quesito chiave riguardo allo stato di salute di FCA e, in particolare, delle strutture produttive in Italia ex-Fiat al momento della fusione con PSA. Si comprenderebbe allora diversamente il senso delle parole della Presidente del Consiglio allorché denunciò il 24 gennaio “la pretesa fusione con il gruppo francese PSA che nascondeva in realtà l’acquisizione della parte francese del gruppo storico italiano.” – il che, fra l’altro, non sembra necessariamente vero sulla base dei rapporti di proprietà che vede la famiglia Agnelli attraverso la finanziaria Exor controllare come azionista di maggioranza relativa il 23,1% dei voti degli azionisti di Stellantis contro l’11,1% della famiglia Peugeot e il 9,6% dello stato francese. È inoltre problematico parlare di “gruppo italiano” a proposito di FCA allorché nel momento della fusione la componente operativa italiana non poteva essere detta preponderante nel gruppo.
Concentrando l’attenzione per amore della brevità sui siti produttivi italiani occorre innanzitutto riconoscere con atto di sincerità che la loro difficile situazione attuale non è che il risultato di un declino in atto da tempo. Questa vede oggi la componente “italiana” chiaramente in posizione fortemente più debole in termini di capacità operativa rispetto a quella “francese” che ha una chiara superiorità già solo nel campo della tecnologia e della capacità progettuale.
Quando Elkann si attivò per trovare un accordo con PSA dopo un primo tentativo fallito con Renault, il gruppo FCA con Fiat, penalizzato da tempo da un cash-flow troppo debole per permettere un flusso stabile e concorrenziale di nuovi prodotti, si trovava in piena ritirata che era cominciata in modo conclamato con la decisione significativa alla fine degli anni novanta di concentrarsi sull’offerta di auto medio-piccole (2 piattaforme, quella A della Panda-Uno e quella B delle Stilo-Ritmo) riservando alla gamma media-superiore il compromesso di una piattaforma B allungata che significò il declino definitivo per marchi come Alfa e Lancia, costruttori acquistati a suo tempo da Fiat prevalentemente a protezione del proprio mercato domestico contro i concorrenti stranieri. I loro modelli furono costretti a condividere con effetto negativo non solo l’architettura ma anche l’impiego di componenti di qualità modesta con il resto della produzione del gruppo di gamma più bassa.
Mentre il mercato si muoveva in una logica di trading-up, come ad esempio i produttori tedeschi, il gruppo Fiat si ritrovò in un trading-down scegliendo per costrizioni economiche di ritirarsi sostanzialmente su un segmento del mercato caratterizzato da bassi margini di profitto e concorrenza crescente, in particolare da parte dei paesi asiatici che possono vantare velocità di progettazione e realizzazione di nuovi modelli superiori a quelle dei concorrenti europei. Il deperimento graduale del know-how, ove ancora negli anni ’90 vi erano validi capisaldi come il common-rail nel settore dei motori diesel, trovò infine l’epilogo in un matrimonio con PSA, che veniva da una rincorsa coronata da un discreto successo nei confronti dei concorrenti tedeschi e che otteneva nella fusione, come accennato sopra, la leadership in termini di strategia, obiettivi e tecnologia in virtù di un migliore posizionamento in termini di risorse e di prodotto. È importante tenere presente che, oltre a quote di mercato e la presenza negli Stati Uniti con Chrysler, tra gli asset della Fiat figuravano le unità produttive in Brasile, Polonia e Turchia – ma non quelle in Italia ove la ripresa produttiva dopo il 2015 fu dovuta principalmente all’introduzione di modelli Jeep e Chrysler, tra cui i SUV, che andarono a attivare, almeno parzialmente, la capacità produttiva non utilizzata. Per questo motivo l’intelligente mossa di Marchionne con il matrimonio con Chrysler del 2014 può essere vista essa stessa come un’altra manifestazione di debolezza avendo tra gli obiettivi l’innesto, senza il peso di costi di progettazione, di nuovi prodotti nel flusso anemico dei veicoli al di fuori della piccola e media cilindrata.
La situazione si è fatta rispetto ad allora ancora più problematica e foriera di nuovi rischi per tutti i produttori europei, inclusi quelli tedeschi – questo in particolare dal momento dell’avvento sul mercato dell’auto elettrica, incluso l’ibrido. Qui il gruppo Stellantis si trova in ritardo rispetto alla concorrenza mentre si teme un’invasione di prodotti cinesi a basso prezzo e prestazioni concorrenziali, soprattutto nell’elettrico. Le fabbriche italiane di Stellantis sono svantaggiate da bassa efficienza e fanno la figura dei vasi di coccio, in particolare Mirafiori, mostrando utilizzazioni della capacità produttiva al di sotto di altri siti di produzione del gruppo Stellantis. Non è un caso che nei programmi del gruppo per l’Italia concordati nel 2021 sia prevista la produzione di quattro modelli di gamma medio-superiore e di progettazione transalpina che grazie a un maggiore margine di contribuzione permettono di sostenere un’intensità di costi di produzione più elevata, almeno per un periodo transitorio.
Di fronte alla necessità di contribuire alla risoluzione di una situazione compromessa permettendo anche un mantenimento soddisfacente dell’occupazione lo stato italiano è chiamato a un impegno che favorisca, nell’ambito di una strategia di politica industriale oggi evanescente, il miglioramento delle condizioni di investimento e gestione imprenditoriale individuando insieme ai costruttori un ruolo delle loro attività nell’auto che permetta un futuro e non meri sussidi “a perdere” in aree in crisi. I campi di intervento possono spaziare dall’istruzione e dalla riqualifica professionale e ricollocamento a tutte le condizioni quadro come l’approvvigionamento di energia stabile e a prezzi concorrenziali, un’infrastruttura efficiente dei trasporti, adeguate norme ambientali e altri elementi portanti di un sistema produttivo senza dimenticare gli importanti aspetti relativi all’amministrazione, incluso un adeguato sistema fiscale e del diritto. L’intervento finanziario dovrebbe avere in tale prospettiva il fine principale di dare impulso e sostenere l’innovazione e l’investimento in campi tecnologicamente avanzati (come ad esempio nel settore delle batterie e dell’impiego dell’idrogeno) – non secondo modelli che ricordano la filosofia di almeno parte delle defunte partecipazioni statali italiane indirizzate al mantenimento di attività, come si diceva un tempo, “decotte” e caratterizzate dalla prospettiva di una probabile perdita sostanziale se non totale di valore. Tale è anche il senso delle raccomandazioni nei suoi libri della Mazzucato che alcuni interpretano invece come una dichiarazione a favore dell’intervento statale in veste di imprenditore che dovrebbe essere riservata a casi nell’ambito dei servizi pubblici o attività produttive di particolare criticità.
In tale ottica si inserisce la contrattazione, pure serrata, sul mantenimento di posti di lavoro, anche con un supporto da parte dello stato nelle situazioni in cui esso è essenziale e uno sviluppo economicamente positivo dell’intervento è da attendersi. Non consigliabili sono in tali contesti atteggiamenti apertamente antagonistici, come manifestato ripetutamente da alcuni nei giorni passati. Essi potrebbero compromettere l’attrazione del nostro paese come destinazione di investimenti rivelandosi controproducenti per l’occupazione che altrimenti si vuole giustamente preservare ed espandere.